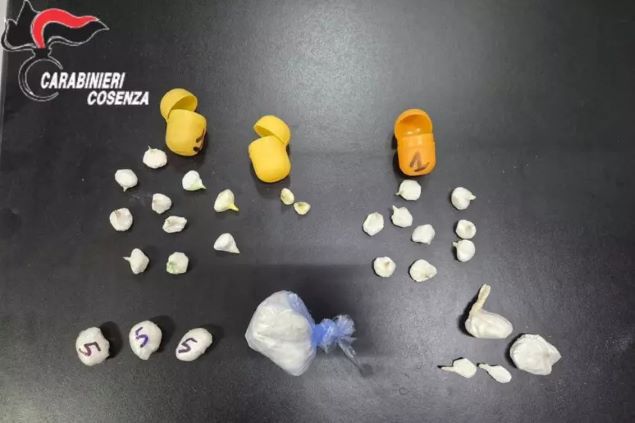Il terremoto del 1638 che colpì la Piana lametina nel trattato del Kircher
11 min di lettura
Il terremoto del 1638 che colpì la Piana lametina nel trattato del Kircher
Athanasius Kircher (Geisa, 2 maggio 1602 – Roma, 28 novembre 1680) è stato un gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco del XVII secolo.
Lo studioso fu il più celebre “decifratore” di geroglifici del suo tempo, malgrado buona parte dei suoi presupposti e “traduzioni” in questo campo da allora siano stati smentiti (egli, tuttavia, condusse uno dei primissimi studi sulla scrittura sacra del Nilo, stabilendo il legame corretto tra essa ed il copto, ragion per cui è stato considerato tra i padri fondatori dell’Egittologia).
Fu una delle più famose personalità del suo tempo in campo scientifico, venendo oscurato verso la fine della sua vita solo dal razionalismo di Cartesio.
Uno studioso moderno, Alan Cutler, lo ha descritto come “un gigante tra gli studiosi del XVII secolo” e “uno degli ultimi pensatori che potrebbero giustamente rivendicare come suo dominio tutta la conoscenza”. Un altro, Edward W. Schmidt, si riferisce a Kircher come all'”ultimo uomo del Rinascimento” , ma in realtà egli non fu un passatista, fu invece completamente uomo del suo tempo, immerso in quella corrente enciclopedica tipica e ben radicata del sec. XVII che si sarebbe poi trasformata e consolidata nel secolo successivo.
Quanto mi accingo a presentare su questo personaggio poliedrico in transito è la traduzione in lingua italiana di una sezione della sua opera: Mundus subterraneus: oggetto del lavoro è la descrizione del terremoto calabrese del 1638, di cui l’autore fa un’analisi autoptica, capillare e abbastanza dettagliata.
Caput II
De horrendis Terrae motibus anno 1638,in Calabria exortis, quibus quattuordecim dierum spatio Author magno vitae suae periculo praesens, eius occasione magna Naturae arcana didicit.
Ego itaque anno 1638 una cum duobus Religiosis tertii Ordinis S. Francisci, aliisque duobus faecularibus conducta cymba, 24 die Martii Messana solventes, eo ipso die Pelorum Siciliae promontorium attigimus, ubi triduum sustinentes, cum nullo non calamitatis genere confliximus, adeo omnes loci, acrisque iniuriae in nos conspirasse videbantur: erant autem haec omnia futurae tragoediae quaedam veluti proscenia; semel in eundem locum repulsi, cum invito mari, tum occulta Dei manu, ut postea patuit, nos remorante, reverti fuimus; quod nisi factum esset, omnes nos in S. Euphemia, quo properabamus, et ubi negotium causa aliquantisper subsistere cogitabamus, mansisset sepulchrum; unde ex hac mirabili Divinae providentiae dispositione didicimus, quam saepe homo nesciat, quid petat et quam vanae et caducae hominum, nisi divinae voluntati submittantur fulcianturque, sint dispositiones. Illucescente itaque die Sabbathi palmarum, quae erat 27 Martii, nos diuturnioris morae pertaesi violentiam quasi profectionem occepimus. Mare eo ipso die praeter solitum aestuabat, et tingentes circa Scyllae potissimumlocum tot naufragiis infamem, vortices turbinato descensu agebat, ita ut non nobis tantum, set et plerisque nautis res insolita horrorem incuteret. Contrario itaque nobis maris aestu phaselum versus Tyndaridas seu Mylas direximus, ut inde proruente Euronoto, breviori et rectiori transitu per Sinum Cujacium ad littora Calabriae propelleremur; at ubi punctum illud maris, quod Liparas inter, Mylas et Promontorium Vaticanum ferme medium est, attigimus; Ego Aetnam et Strongylum diligentius intuitus, eos ingentes fumorum globos, montium adinstar, praeter solitum eructare notabam, quibus longe lateque diffusis, non Lipararum tantum, sed et Siciliae quoque aspectus ex oculis penitus tollebatur: augebant horrorem subterranei quidam veluti mugitus, quos percipiebamus et fragores cum odore sulphureo, qui nescio quid fatale et funestum insussurrantes in totius Calabriae et Siciliae exitium, quod parabant, unanimi consensu conspirasse videbantur. Ego huiusmodi impendentium calamitatum prodromis exterritus nautas omnibus, quibus poteram, modis precibusque sollicitabam, ut relicta ora Liparitana, Promontorium Vaticanum recta peterent, addens in magno nos discrimine versari, ne maris aestu abrepti, iter pararemus irremeabile: Nam Strongylo cum essemus vicini, eum tamen utpote fumo obvelatum non cernebamus, fragores solum cum odore sulphureo graveolente, quem exhalabat, sensimus: praeterea mare ipsum fervere, et in aquae bullientis morem agitari, coelo praesertim silente et serenitate claro, aliasque huiusmodi insolitas alterationes subire omnes mirabamur: qui tempore pluviae lacum unquam vidit, innumeris bullulis ferventem, is de maris bullientis fervore, hoc ipso tempore judicium formare poterit. Porro cum jam capiti Vaticano appropinquassemus, durantibus adhuc iisdem maris symptomatis, ego futuras calamitates quasi praesentiscens, ex inassueta mentis angustia animum meum constringente, palam sociis meis ingentem mox terraemotum secuturum, praedixi; imo valde me vereri, ne totus hic pendentium scopulorum tractus prostratus corrueret, proinde ei non nimium appropinquaremus: augurium probavit eventus, post duas enim circiter horas, magnam hujus Promontorii partem una cum vicinis habitationibus concidisse audivimus: interim iter nostrum prosecuti, Tropaeam incolumes omnes et summo gaudio tandem appulimus, ignari iis periculis, quae paulo ante in fervido mari vix evaseramus, modo primum nos infestandos etsi morti vicinos nos esse, coelo praesertim sereno, et fine nube illa, ne quidem suspicari poteramus. Verum enim vero vix Collegii nostri limina subieram, cum ecce subterraneum eumque formidabilem adinstar curruum summa velocitate agitatorum sonum et strepitum, adeo vehemens et horribilis terrae motus excepit, ut Collegium una cum oppido subiectoque monte veluti in bilance librari viderentur; Terra adeo vehementi motu subsultabat, ut ego pedibus amplius consistere non valens, subito in terram illisus prono vultu prosternerer, ea quae ante mecum animo praesentiscente volueram ipso facto incurrens, animam Deo incessanter, desperata jam vita commendabam. O quam in hoc angustiae puncto omnia Mundi gaudia desipiebant;quam uno ictu oculi omnis honor, dignitas, imperium, sapientia, nil aliud nisi sumus, bulla, stipula a vento rapta esse videbantur; dum in porta aeternitatis stans, animam corporeis solutam vinculis ad incorruptibilis vitae usuram capessendam transmittere pararem; quod sane ipso momento contigisset, nisi Deo Opt. Max. me singulari gratia sua a ruina murorum praeservatum, ad duriora pro Nominis fui honore et gloria sustinenda destinare visum esset. In hac mentis lucta, ingentem formidinem cum tegularum cadentium fragores, tum fatiscentium murorum crepitus incutiebant, dum quo fugerem, aut qua ex parte me servare possem, ruinam jamjam ex omni parte murus minitantibus, dispicere non possem; resumpto tamen animo evasi, ita tam attonitus, ut cum redditus mihi essem, sine pileo et pallio me reperirem, quibus tamen recuperatis, sine mora urbem fugiens, ad cymbam nostram me contuli, hac eadem mentis consternatione, tum Patres nostri, tum quotquot me concomitabantur, laborarunt, dum unusquisque de salute sua sollicitus, ut poterat, vitae fuga, veluti muti atque omni vocis usu destituti, consulere satageret. Postero die, quae erat Dominica Palmarum, iter nostrum prosecuti, mari fervente et mirum in modum tumido Rochettam pervenimus, at descensione facta, febris Terre recrudescens, ita ingenti eam concussit paroxysmo, ut cymba ob ingens periculum, quod ex intolerabili Telluris rabie nobis imminebat, repetenda foret. Erat ibidem domus vicina peregrinis hospitibus recipiendis apta, in quam nos nonnihil quietis capiendae gratia recepimus; at recrudescente Terrae tremore; ego ingentis ruinae nobis imminentis praefagus, aperte dixi, qui vitam in tuto collocare desiderat, is mecum littus repetat, ac proinde hisce commoti verbis comites continuo relicta domo me secuti sunt. Vix ad dimidium horae nobis in littore commorari concessum fuit, cum ecce denuo Terra solito majori ferocia saeviens, et complura ex circumsitis locis, et hospitium, quod paulo ante deserveramus, vehementi insultu concutiens, non nisi lapidum calcisque acervo post se relicto, postravit, gratias proinde, quas potuimus, maximas Divinae Majestati egimus, quae nos a tam imminenti periculo per occultos instinctus eripuerat. Locum itaque in quo a tanta terrae excandescentia tutos securosque nos conservaremus, dum quaerimus, ulterius progressi, Lopizium, medium Tropeam inter, et S. Euphemiam Castellum pertigimus, ubi favorem ventorum, quo sinum transfretare possemus, operientes, ab una parte mare vorticibus exhaestuans, ab altera parte ingens castellorum pagorumque strages, quo nos verteremus nescii, incredibilem metum incutiebant. Hisce calamitatibus dum jactamur, ego curiosius intuitus Strongylum 60 fere milliarium intercapedine dissitum, illum insolito modo furere notavi, totus enim ignibus oppletus videbantur, tanta copia, ut montes flammeos eructare videretur, spectaculum visu horrendum, et animo quantumvis intrepido formidandum. Interea sonus quidam adinstar tonitrui, verum ob remotam, qua oriebatur, distantiam, paulo obtusior percipiebatur, qui tamen semper majus majusque in subterraneis cuniculis incrementum sumebat, donec locum subterraneum, cui insistebamus, teneret; ubi tanto fremitu et indignatione concussit terram, ut pedibus amplius consistere impotens, arrepto, quo quisque poterat, obviovirgulto aut frutice maritimo, ne membra nimia concussatione laxarentur, sustinere se cogeretur. Contigit hac eadem hora res aeterna et immortali memoria digna, subversio videlicet celeberrimi oppidi, quod S. Euphemiam dicunt: Erat hoc in extrema sinus ora situm, sub Equitum Melitensium jurisdictione. Cum itaque ad Lopicium, ex vehementi Terrae subsultatione, veluti exanimes in terra prostrati, tandem subsidente Naturae paroxismo, oculis in circumjacentia loca conjectis, ingenti nebula, paulo ante memoratum oppidum circumdatum vidissemus, ter sane post meridiem hora tertia praesertim coelo sereno mira et insolita nobis videbatur; dissipata vero paulatim nebula oppidum quaesivimus, sed non invenimus, mirum dictu, lacu putidissimo in ejus locum enato. Quaesivimus homines, qui de insolito rei eventu, nonnihil certi nobis enarrare posset, sed formidabilis casus tantaeque stragis nuncium non reperimus. Nautae ad hoc spectaculum veluti attoniti, et incredibili formidine perculsi, projectis remis tundentes pectora Divinam implorabant Misericordiam, propediem non nisi eandem fortem, aut ultimi Judicii diem exspectaturi: Confortati tandem ac poenitentiae sacramento expiati, Deo duce inter tumentes maris fluctus littus oppositum tenuerunt, ubi exscensione facta denuo homines quaesivimus, sed praeter puerum in littore sedentem veluti stupore attonitum, inventus est nemo; hic interrogatus a nobis, quidnam S. Euphemiae contigisset, sed muto locuti nihil extorsimus, metus enim vehemens et formidabilis eventus linguam animumque ita consternarat, ut nec verbis commiseratione plenis, ne cullo charitatis officio ejus animumdevincire nobis possemus; cibum oblatum omnem penitus nimio dolore et moerore oppressus aversabatur, digitis solum extensis Sanct-Euphemianam catastrophen innuere videbatur. Consolationis itaque omnis expers, vultuque substricti et capta mente homini similis, a nobis recedens in proximam sese sylvam proripuit, numquam amplius visus. Nos itineri insistentes Nicastrum, Amantea,. Paulam, Belvederium transeuntes, nil aliud ad 200 millia passuum, nisi cadavera urbium, castellorumstrages horrendas reperimus, hominibus per apertos campos palantibus, et prae timore veluti exarescentibus; Ultimi Judicii diem jam jam imminere dixisses. His magno nostri stupore simul et dolore visis, tandem inter ingentia aestuantis maris pericula, infelici sane itinere Neapolim tandem tenuimus. Quid jam mihi acciderit, sequentibus Lectori paucis exponam.
Libera traduzione
«Il 27 marzo del 1638 lasciammo la costa siciliana all’alba; il mare era insolitamente agitato e si avvolgeva in orribili gorghi specialmente intorno alla rocca di Scilla famosa per tanti naufragi. Eravamo impauriti; e non solo noi, ma anche i marinai più coraggiosi tremavano davanti a quello spettacolo.
Quando raggiungemmo felicemente quel tratto di mare che è tra Lipari e Capo Vaticano, scrutai con attenzione l’Etna e lo Stromboli; essi eruttavano masse di fumo immense come montagne che, spingendosi verso sud, subito nascosero alla nostra vista non solo le isole Lipari, ma anche tutta la Sicilia.
Spaventati ci dirigemmo velocemente verso Capo Vaticano e passammo vicino allo Stromboli senza poter vedere quell’isola avvolta da impenetrabili nuvole di fumo; le nostre orecchie erano stordite da forti boati e la nostra respirazione impedita da un acre odore di zolfo.
Malgrado il tempo fosse sereno e l’aria calda, la superficie del mare era violentemente agitata e l’acqua, che gorgogliava come se bollisse, sembrava sottoposta alle più straordinarie alterazioni del suo stato naturale. Chiunque durante un violento acquazzone ha osservato le numerose bolle che fa la superficie di un lago potrà un’idea esatta di come bolliva questo mare.
Appena ci avvicinammo al Capo il protrarsi dei sintomi terrificanti mi causò un insolito abbattimento e mi fece avvertire una specie di sentimento profetico dell’avvicinarsi della calamità.
In questo stato angoscioso gridai ai miei compagni che stava per determinarsi un violento terremoto e che avevo molta paura di avvicinarmi al Capo poiché avremmo potuto essere sepolti sotto le rovine delle sue rocce le quali, secondo me, si sarebbero staccate dal continente e sarebbero state scagliate con violenza nel mare.
I fatti confermarono le mie previsioni poiché circa due ore dopo, come poi ci fu detto, un grosso masso di questo promontorio si staccò e precipitò in mare con tutte le abitazioni che si trovavano sopra. Intanto continuammo il nostro viaggio e sbarcammo salvi e felici a Tropea non pensando minimamente che i pericoli del mare da cui eravamo sfuggiti erano del tutto insignificanti rispetto a quelli che ci attendevano sulla terra.
Eravamo illusi dall’apparente calma del cielo quando, mentre stavamo per attraversare la soglia del nostro collegio, ad un boato sotterraneo fragoroso come carretti che corrono a velocità pazza seguì una così terribile e violenta scossa sismica che il collegio, la città e la rocca oscillarono come se stessero in bilico.
La terra ebbe un sobbalzo così forte che, non potendomi reggere in piedi, caddi disteso sul pavimento. Appena mi ripresi, corsi velocemente giù dalla collina verso la mia barca e la misi in mare.
L’indomani, sebbene il mare fosse agitato e tempestoso, raggiungemmo La Rocchetta, ma quando sbarcammo le scosse le scosse sismiche ripresero con nuova furia e ci indussero a cercare sicurezza alla nostra barca. Remammo alla ricerca di qualche posto sicuro e non avevamo ancora lasciato la zona quando l’intero villaggio della Rocchetta fu raso al suolo ed i suoi abitanti sepolti sotto le rovine. Sbarcammo oltre Pizzo, dove però la nostra posizione sembrava più pericolosa che mai.
Da una parte c’erano alte montagne, dall’altra la vista desolante di città e villaggi distrutti. Rivolsi un’occhiata allo Stromboli e lo vidi eruttare con insolito vigore; un lenzuolo di fuoco lo copriva tutto; non si sarebbe potuta vedere una conflagrazione più spaventosa. Ad un tratto una specie di suono sordo, come un tuono lontano, serpeggiò lungo le viscere della terra diventando sempre più forte fino a che giunse sotto i nostri piedi.
Qui le vibrazioni del suono ed rumore divennero spaventosi al di là di ogni immaginazione ed ognuno, accorgendosi che i piedi non potevano più tenerlo in equilibrio, si aggrappò ai rami ed agli arbusti alla riva per paura che i suoi arti si disunissero per i vari e diversi movimenti della superficie su cui si trovava.
Quando la terra si riprese da questa convulsione e noi risorgemmo come delle tombe per guardare ancora una volta su verso la luce del cielo, volgemmo gli occhi in direzione della vicina città di Sant’Eufemia, ma nel luogo dove ci aspettavamo di trovarla un’oscura nuvola copriva ogni cosa; come se si fosse dissolta, al posto delle case e delle chiese non c’era altro che un fetido lago! Quasi pietrificati dallo stupore ci affrettammo a cercare qualche superstite che ci potesse dare spiegazioni.
Non si vedeva anima viva, fino a quando non c’imbattemmo in un giovane seduto sulla spiaggia istupidito dal terrore. Gli domandammo notizie sulla sorte di Sant’Eufemia, ma non avemmo alcuna risposta poiché la paura, il dolore e la disperazione gli avevano tolto la parola e gli avevano raggelato l’anima.
Né le nostre gentili profferte, né i termini affettuosi riuscirono a cavargli una sola parola. Sopraffatto dal dolore egli si rifiutò con disgusto i viveri che gli porgemmo, ma ebbe solo la forza di stendere il braccio ed indicare il luogo dove c’era stata Sant’Eufemia.
Così, chiuso ad ogni conforto, con gli occhi bassi e l’espressione di un uomo sconvolto dal dolore si allontanò nascondendosi nel bosco vicino.
Continuammo il nostro cammino attraverso vari luoghi ed in mezzo a scene di desolazione e per duecento miglia non vedemmo altro che città diroccate e persone che vagavano nei campi, quasi folli per la paura. Poi, fu la volta della città partenopea su cui il lettore sarà informato successivamente».
Prof. Francesco Polopoli