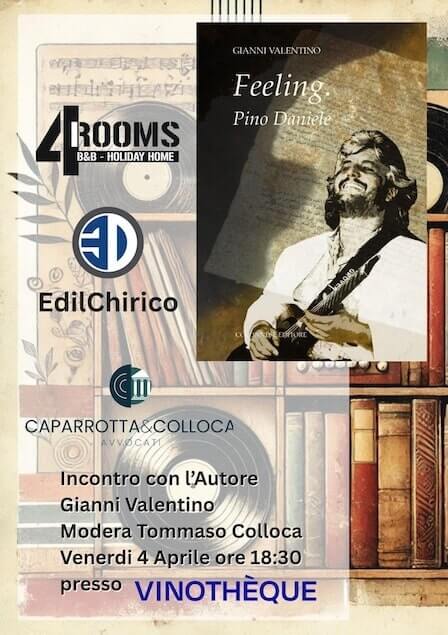“Amleto + Die Fortinbrasmachine” o del Teatro come luogo dell’utopia
5 min di lettura
Lamezia Terme, 10 luglio 2021. Al Teatro “F. Costabile” l’ultimo spettacolo del Matrioska Festival ideato e realizzato da Mammuth Teatro, direzione artistica di Gianluca Vetromilo, direzione organizzativa Armando Canzonieri, collaborazione artistica e organizzativa Achille Iera.
In scena Amleto + Die Fortinbrasmachine di e con Roberto Latini che firma la drammaturgia insieme a Barbara Weigel. Musiche e suoni di Gianluca Misiti. Luci e tecnica di Max Mugnai. Una produzione Fortebraccio Teatro in collaborazione con L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, ATER Circuito Regionale Multidisciplinare – Teatro Laura Betti, Fondazione Orizzonte d’Arte con il contributo di MiBACT e Regione Emilia Romagna.

“Where is this sight?” Dov’è questo spettacolo? Lo spettacolo è nella frantumazione dell’io che coincide con il suo dissolvimento –“Chi sono io?”, “Potrei dire di essere tutto ciò che non sono” – dove la soppressione di realtà serve a scatenare una rappresentazione dell’esistenza che mostra un’altra realtà, interiore ed esteriore insieme, fatta di analogie, di contraddizioni, di verità.
Dal testo di Heiner Müller, Die Hamletmachine, che è una riscrittura dell’Amleto di Shakespeare, per Latini parte la scrittura scenica di Amleto + Die Fortinbrasmachine. Un testo erratico e oscillante, vivificato da una lingua multipla tesa ad esplorare il futuro della memoria con una partitura densa e rappresa in cui l’incresparsi sardonico dei toni rende suoni assai spesso sinistri pur levigati da spiragli di humour nero.
E il lavoro sulla scena sembra affermarsi come per via di un segreto piacere di far teatro, di un deciso, intimo divertimento e dilaniamento lungo una linea (a)temporale che combina passato e presente, nel tentativo di esplorare le possibilità utopiche dell’arte testimoniando la ricerca, senza fine, del senso e la sua perdita.
In Latini, l’intertestualità e l’attraversamento dei generi costituiscono un metodo e, nello stesso tempo, esprimono una inquietudine non formale che dalla scrittura si evidenzia come motore primo del suo operare.
Del testo di Müller ne conserva l’architettura e l’incipit del primo quadro Album di famiglia usato, qui, come finale, mentre l’Amleto di Shakespeare diventa un pre-testo e un pretesto, perché un testo classico è sempre una scrittura in movimento, al di là della propria epoca.

La scena mostra un décor quasi nudo perimetrato da quinte nere e pochi, evocativi elementi, simulacri di un teatro che fu. Una sorta di stanza della tortura o della memoria concepita come proiezione di un vuoto denso di sommovimenti che costituiscono l’esatto riscontro delle sfasature e delle intermittenze della coscienza di questo solipsistico canto polifonico in cui dialogano La Dichiarazione Umana dei Diritti dell’Uomo, Macbeth ed Eduardo, Amleto e il Pater Noster, Marilyn e il fantasma di Polidoro, Blade Runner e Agatha Christie.
Lo spazio teatrale – nel suo buio percorso da musica e voci, perforato da rintocchi di campane, spari, scampanellii, colpi ritmici, schiocchi di cinghia, suoni stridenti di ferraglia – appare quasi come un grande grembo che genera i personaggi i quali, spesso, ripartono come per effetto di un vecchio vinile graffiato in qualche punto e con i quali l’attore si confronta.
Così, in alchemica somma di armonia razionale ed emotiva, Latini traduce in un movimento gelidamente astratto il turgore delle passioni con tutti i loro ornamenti idealistici attraverso una dislocazione enfatica della scrittura verbale e della mimica deformante e allusiva. Si beffa del tragico senza rompere le regole del gioco, corrodendo la dimensione patetica dei personaggi fino allo sberleffo grottesco, al riverbero crudele, alla piacevole perfidia teatrale.
 Egli si presenta in scena con un trucco gessato da teatro orientale e sembra avere scolpiti sul viso, sulla pelle, sulle mani i segni di una riesumazione antica mentre si affacciano, impercettibili, le genialità di una regia senza concessioni e attentissima ai particolari, ai movimenti, ai gesti: la postura eretta, quasi regale nella sua verbigerante fissità, la buffa sensualità che si concede sculettando nei panni della Monroe (affettuoso omaggio al Bob Wilson di Hamlet. A monologue?), la provocazione giocosa delle rosse décolleté da cortigiana, lo spettro/armatura sulla sedia a rotelle, segno inerme di gloria svuotata dalla falsità e dall’inganno, in dialogo muto con la morte in mezza maschera disegnata con compiaciuto grafismo fumettistico, la quotidianità che irrompe sulla scena con un televisore, supporto visivo e specchio di un magmatico presente privo di memoria ma anche simbolo di una omologazione della società capace di creare, nella sua immaterialità risucchiante, solidissime illusioni.
Egli si presenta in scena con un trucco gessato da teatro orientale e sembra avere scolpiti sul viso, sulla pelle, sulle mani i segni di una riesumazione antica mentre si affacciano, impercettibili, le genialità di una regia senza concessioni e attentissima ai particolari, ai movimenti, ai gesti: la postura eretta, quasi regale nella sua verbigerante fissità, la buffa sensualità che si concede sculettando nei panni della Monroe (affettuoso omaggio al Bob Wilson di Hamlet. A monologue?), la provocazione giocosa delle rosse décolleté da cortigiana, lo spettro/armatura sulla sedia a rotelle, segno inerme di gloria svuotata dalla falsità e dall’inganno, in dialogo muto con la morte in mezza maschera disegnata con compiaciuto grafismo fumettistico, la quotidianità che irrompe sulla scena con un televisore, supporto visivo e specchio di un magmatico presente privo di memoria ma anche simbolo di una omologazione della società capace di creare, nella sua immaterialità risucchiante, solidissime illusioni.
Con l’ausilio di microfoni posizionati a tracciare un ideale triangolo, egli muta il valore dei timbri della voce passando attraverso il volume sonoro degli shock e delle scosse emotive, brevemente indugiando in una specie di “recitar cantando”, con un tocco pop di singolare effetto espressivo, fino a raggiungere i margini nichilisti di una linea drammaturgica abbandonata al piacere del linguaggio che si “lascia agire” e opera per trasformazioni e mimesi, non del reale, ma dell’immaginario, riconoscendo i propri interlocutori per sotterranee affinità.

Una struttura drammaturgica che alterna una crudeltà quasi circense agli sprazzi di una poesia che intimamente fa continui approcci con la materialità, in una compresenza di istanze spirituali e di insoddisfazione da uomo dei nostri tempi. Un gioco continuo di slipping in e out, di sdoppiamenti e di moltiplicazioni che complica e chiarifica, l’una all’altra, le parti del tutto, che affascina il pubblico, lo incuriosisce, lo inquieta.

In questo spazio dell’assenza, popolato di ombre e di suoni, la parola si frammenta, esplode, si attorce su sé stessa, si amplifica in echi e percussioni che ne costituiscono l’ossatura sonora. È silenzio. È pietra o piuma che si sbranca nella pluralità dei codici linguistici (latino, italiano, inglese, tedesco). È voce spogliata, intesa come metafora e come ritmo senza cadute, quindi come pensiero e come materialità fisica e oggettuale sulla scena. Una voce imprendibile, a tracciare un percorso tutto interiore, variabile in assonanze e perdute dissonanze, a tessere una sinfonia totale, assolutamente antimelodica e antimimetica che diventa “musica senza canto”.
Silenzio. Buio. Applausi lunghi e catartici di spettatori felici/smarriti/sgomenti, preda di una potente vertigine scenica dalla teatralità espansa, ma inafferrabile.
Giovanna Villella
[credits_Angelo Maggio]